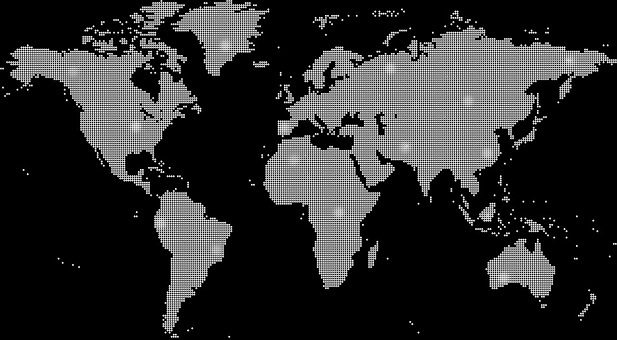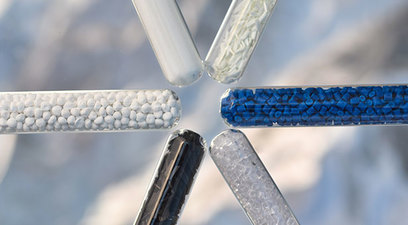Essere pronti al rischio epidemia
I contraccolpi economici dell’epidemia di Coronavirus si stanno facendo sentire ed erano prevedibili: si va dalle conseguenze del blocco produttivo in Cina, al settore turistico che sta risentendo già nell’immediato della paura del contagio e delle misure di contenimento che sono state messe in atto.
Per quanto riguarda il comparto produttivo, le imprese avrebbero potuto non farsi trovare impreparate, adottando per tempo dei piani di emergenza. L’invito non cade dal nulla: il World Economic Forum da alcuni anni colloca il rischio di pandemie tra i più temibili per potenzialità dell’impatto, proprio perché è forte l’eventualità che colpendo la popolazione si blocchino intere catene economiche. “Si tratta di mettere in atto per tempo misure di contenimento del rischio - afferma Alessandro De Felice, presidente di Anra, l’associazione dei risk manager italiani - molte imprese lo hanno potuto fare perché hanno adottato un sistema di risk management che in un’ottica di gestione del rischio valuta anche le conseguenze di simili eventi”. Ci sono stati in questi primi vent’anni del Duemila alcuni accadimenti che già hanno messo alla prova la capacità di garantire la continuità aziendale (business continuity, in opposizione alla business interruption): le epidemie di Sars nel 2003, di febbre suina nel 2009, di Mers nel 2012; e poi eventi catastrofali come lo tsnunami in Giappone nel 2011 o l’esplosione nel porto di Tianjin, in Cina, nel 2015.
L’importanza di un’alternativa
Simili fatti hanno reso palese a molte imprese la necessità di dotarsi di alternative in caso di blocco della catena di approvvigionamento. Da questo punto di vista, afferma De Felice, “vanno considerate innanzitutto l’operatività della supply chain e la possibilità di spostare la produzione presso altri fornitori. In termini di gestione del rischio si tratta di aver approntato per tempo piani di business continuity e di disaster recovery. L’aspetto temporale è fondamentale perché non è possibile ricorrere a soluzioni su questi complessi aspetti operativi in poco tempo: dopo eventi come lo tsunami o l’incendio a Tianjin ci sono state molte imprese che hanno ritenuto opportuno riportare una parte delle produzioni in Europa”.
Uno dei temi chiave è la dipendenza dell’attività aziendale da uno specifico distretto produttivo o da un determinato fornitore strategico: “l’impresa deve poter valutare quanto della sua business continuity è legata ad un singolo supplier; in questo senso la sua centralità deve essere gestita, riducendo la dipendenza o pretendendo da lui una determinata capacità di gestire il proprio rischio”. Un altro esempio concreto di “modello alternativo” utile a gestire l’emergenza si è visto proprio in questi giorni, con molte imprese che erano già organizzate per poter far lavorare da casa i propri impiegati, così da non aver avuto grandi contraccolpi a seguito dell’invito delle autorità di ridurre per quanto possibile i contatti tra le persone per evitare i contagi.
Non tutti subiscono lo stesso impatto
In ogni modo, la sospensione delle attività nel sistema produttivo cinese sta avendo ricadute importanti in tutte le economie del pianeta. L’impatto è differente a seconda del settore merceologico e del tipo di produzione per la quale l’azienda è legata alla Cina. I settori più colpiti dallo shut-down delle attività sono l’automotive, l’It e la telefonia; rispetto invece al tipo di attività che le imprese svolgono nella repubblica popolare, De Felice identifica tre modalità prevalenti: “le aziende che ricevono componentistica dalla Cina, quelle che hanno delocalizzato tutta o una buona parte della propria produzione, e infine le imprese che hanno filiali in Cina nelle quali producono per il mercato locale. Nel primo caso, si è accumulato un ritardo minimo nella produzione di due settimane, a cui vanno associate le difficoltà legate alla logistica. In assenza di fornitori alternativi, le aziende rischiano di dover sospendere la produzione nel proprio paese per mancanza di componenti. La seconda categoria è quella maggiormente esposta, perché se ha una produzione delocalizzata in Cina si trova oggi con l’intera catena logistica bloccata, e un fermo produttivo di qualche settimana può risultare molto critico per la sopravvivenza dell’impresa. Le aziende che invece producono nel territorio cinese per il mercato interno avranno un impatto certamente negativo, ma limitato solo a quell’area geografica”. In linea di massima, una sospensione delle attività produttive di due settimane può essere assorbita dall’impresa senza gravi conseguenze; diversa è la questione per quanto riguarda settori come il turismo, le fiere, l’entertainment, la ristorazione, che hanno ricadute immediate sugli introiti e sull’occupazione, e nella maggior parte dei casi l’impossibilità di recuperare gli incassi perduti.